“Dottore, cosa dovremmo fare? Sarebbe meglio portarlo in una struttura o tenerlo qui con noi?”
È questa, forse, la domanda più carica di angoscia che i familiari rivolgono ai medici di famiglia. È una domanda che nasce dall’amore, ma anche dalla paura di non essere all’altezza. Avendo lavorato per anni all’interno di contesti clinici e strutture, e occupandomi oggi quotidianamente di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), mi sono fermata spesso a riflettere su questo bivio e questo doppio punto di vista mi ha portata a farmi una domanda semplice solo in apparenza: è davvero meglio assistere la persona in struttura o a domicilio? La verità? Non esiste una risposta valida per tutti, ma esistono diverse “verità” della cura.
La struttura: sicurezza e comunità
Le strutture offrono qualcosa che il domicilio spesso fatica a garantire: la presenza costante. Tra i vantaggi abbiamo indubbiamente il valore della protezione: in struttura, il monitoraggio medico è continuo e l’emergenza viene gestita in tempo reale. Per molti familiari, questo significa poter finalmente dormire una notte intera senza l’allerta costante del “non lo sento respirare”. Inoltre, la struttura favorisce la socialità, spezzando l’isolamento, offrendo momenti di condivisione che a casa, purtroppo, tendono a scomparire.
Tuttavia vi sono dei limiti da non sottovalutare. Il primo rischio è la “depersonalizzazione”. Per quanto eccellente sia una struttura, il paziente deve adattarsi ai ritmi del reparto, perdendo quei piccoli riti (il caffè nella propria tazzina, l’odore della propria casa, la presenza dei volti familiari, ecc…) che definiscono chi siamo. E, non meno importante, e chi lavora nel settore lo sa, spesso la risposta ufficiale “in struttura c’è assistenza h24” non sempre corrisponde alla realtà quotidiana. Il personale può essere limitato, i turni lunghi ed estenuanti, le urgenze tante. E quando l’organizzazione è al limite, può accadere che il paziente venga assistito “quanto basta”. Non è cattiveria. È burnout, esigenze di struttura, difesa emotiva. Ma per la persona che riceve assistenza, per la sua dignità, il risultato è lo stesso. Sul piano psicologico, la persona vive un processo di istituzionalizzazione: perde controllo, abitudini, ruoli. Il che può essere profondamente disorientante.
Il domicilio: l’identità che resiste
L’assistenza domiciliare mette in rilievo una realtà diversa. Il domicilio non è solo un luogo fisico, è un luogo terapeutico. A casa, il paziente non è “il letto 14“, è il padre, il marito, il nonno. Le pareti parlano di lui, e questo ha un impatto enorme sia sulla salute mentale che sulla motivazione alla cura, favorendo così la continuità della vita. Inoltre, per chi soffre di patologie respiratorie o degenerative, il domicilio permette di integrare i macchinari nella vita quotidiana, rendendoli meno “invasivi” psicologicamente, favorendo una migliore gestione della cronicità.
Tuttavia, esiste anche in questo caso il rovescio della medaglia, ovvero la sfida dei caregiver, in quanto il carico emotivo e fisico che pesa sulla famiglia può essere davvero eccessivo. Senza un supporto psicologico adeguato, il domicilio può trasformarsi da nido a prigione per chi assiste. Dal punto di vista psicologico, la casa può proteggere dall’appiattimento emotivo e dalla regressione limitando, al contempo, il carico emotivo dei caregiver.
Punto di vista
Se la situazione clinica lo consente, credo fermamente che la casa sia il luogo dove la dignità della persona risplende di più. L’obiettivo dell’ADI non è solo portare assistenza medica o una macchina a casa, ma trasferire nel domicilio la competenza della struttura mantenendo il calore della famiglia.
Ma la cura a domicilio è possibile solo se le famiglie non vengono lasciate da sole, perché un buon sistema di cura è quello che resta umano. Quindi, la domanda più onesta da porci non è: “meglio una struttura o meglio a casa?” ma: “questa persona dove può vivere oggi la miglior qualità di vita possibile, in sicurezza, senza che nessuno venga schiacciato dal carico di cura?”.
Struttura o domicilio non sono alternative in competizione. Sono strumenti.
La vera cura accade quando ricordiamo che davanti a noi c’è una persona, non un caso, non un numero, non un letto, non una pratica. E quando, anche noi operatori, possiamo prenderci cura di noi stessi, per non diventare indifferenti. Perché la cura, prima di essere tecnica, è relazione.
In conclusione, non c’è una scelta giusta in assoluto, c’è solo la scelta più sostenibile per quel paziente e per quella specifica famiglia.
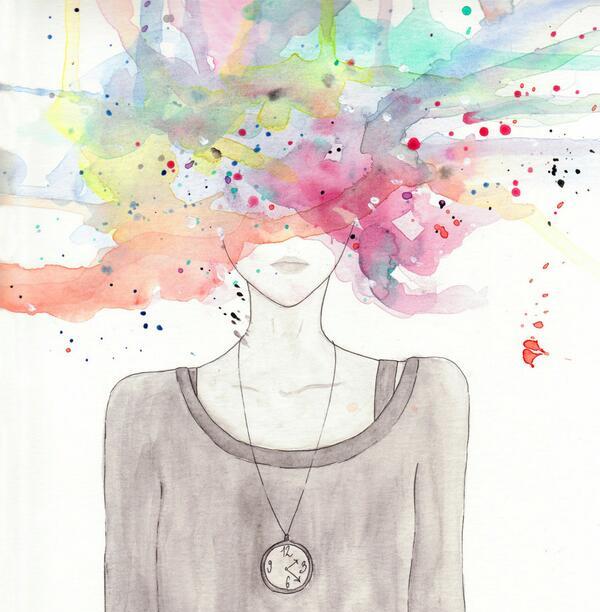

Lascia un commento